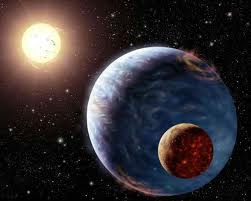Il federalismo fiscale non è più una bandiera di propaganda politica, sventolata da una fazione ed osteggiata dall’altra; quasi tutti i partiti si mostrano favorevoli alla ratio che ispira questa riforma “in progress”, secondo la quale, in soldoni, sarebbe auspicabile responsabilizzare gli enti territoriali subordinati allo Stato centrale, e ciò in ossequio ad un previo assunto generalmente condiviso: che soluzioni politiche efficienti possano essere reperite soltanto dagli organismi territoriali prossimi al corpo sociale presso il quale andranno applicate.
Federalismo fiscale e principio di sussidiarietà
L’idea, insomma, è che l’orecchio della politica si debba avvicinare alla voce di chi la interroga, che le sue parole debbano smettere di echeggiare – spesso incomprensibili – per i palazzi del governo centrale, e debbano farsi carico di suonare amiche all’orecchio del singolo cittadino, là dove egli vive e lavora, possibilmente per risolvergli qualche problema.
Bisogna anche sottolineare che la logica del decentramento degli approvvigionamenti tributari, unitamente alla decentralizzazione delle competenze decisionali inerenti materie tradizionalmente riservate alla potestà normativa dello Stato, cooperano alla creazione di un modello solo fiscalmente federale, in realtà più che mai rispondente alle sollecitazioni suggerite dalla più genuina interpretazione del principio di sussidiarietà. Non a caso questa riforma trova ampio consenso tra le file del mondo cattolico, sempre attento alla difesa e alla riaffermazione del principio di sussidiarietà, la cui formulazione classica, contenuta nell’Enciclica Quadragesimo anno di Pio XI, suona significativamente così: “È vero certamente che [...] molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle”. In sostanza, sia che si tratti di attività riservate al singolo individuo, sia che si abbia riguardo a mansioni assegnate ad organismi sociali, il principio di sussidiarietà tende a preservare la centralità della persona, che non cessa, nell’ambito della comunità, di essere il fine di ogni agire umano, tanto individuale quanto aggregato.
Devoluzione e federalismo fiscale: un problema di giustizia distributiva
La tendenza al decentramento si è affermata già a partire dalla riforma costituzionale del 2001, la famosa devolution, con la quale si è capovolto il criterio di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni: l'articolo 117 della Costituzione prevede ora una lista tassativa di materie soggette alla potestà legislativa statale, affiancata da un elenco, altrettanto cogente, di materie sottoposte alla cosiddetta legislazione concorrente, per le quali cioè la potestà legislativa spetta sempre alle regioni, ma nel quadro di princìpi fondamentali posti dalla legge statale. Il quarto comma dello stesso art. 117, inoltre, prevede che sulle materie di non esclusiva competenza statale o non sottoposte a legislazione concorrente, possano legiferare soltanto le regioni.
A questo punto, se un’entità politica deve assolvere a compiti sempre più vasti, divenire alleata dei cittadini e capace di operare direttamente allo stesso livello territoriale presso il quale essi stessi si trovano, sarà anche necessario dotarla delle risorse economiche e finanziarie indispensabili non solo per prendere delle decisioni, ma pure per renderle effettive all’interno dell’universo socio-economico che le sarà affidato. In Italia l’approvvigionamento di risorse destinate agli enti territoriali subordinati allo Stato, quali le regioni, le province o i comuni, si è sempre realizzato mediante il sistema dei trasferimenti: il gettito fiscale, in sostanza, era indirizzato allo stato centrale, il quale provvedeva poi a far giungere agli organismi territoriali inferiori i mezzi ritenuti necessari allo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Epperò il criterio di determinazione delle risorse gestite dagli organismi politici decentrati consisteva nel riconoscere loro fondi sufficienti a coprire le spese che essi stessi dichiaravano: è questo il cosiddetto criterio della spesa storica, meccanismo che di certo non incentiva all’efficienza – giacché più un amministratore spende, più riceverà – e soprattutto genera un’ingiustizia redistributiva difficilmente giustificabile, poiché per questa via le regioni più produttive, che contribuiscono maggiormente alle entrate fiscali, finiscono per partecipare proporzionalmente meno ai benefici da esse derivanti in termini di spesa pubblica.
Al contrario di quel che la stampa sovente suggerisce, questi temi non riguardano opinioni di natura politica: sin qui si tratta semplicemente di prendere coscienza di un problema, perché difficilmente si potrebbe definire giusto uno Stato che riconosca meno a chi contribuisce di più.
Dalla “spesa storica” ai “costi standard”: il cuore della riforma
Sotto l’impulso di una simile richiesta di giustizia – del tipo che Aristotele avrebbe definito “giustizia distributiva” – e ancora assecondando quella filosofia politica che auspica una maggiore autonomia degli enti territoriali subordinati allo Stato, il Parlamento ha delegato al Governo i poteri per attuare un federalismo fiscale che ruoterà su un nuovo meccanismo di attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali.
In base al primo blocco di decreti approvato dall’Esecutivo, infatti, a partire dal 2012 si provvederà a riporre in soffitta il vizioso criterio della spesa storica, per approdare, già nel 2017, alla definitiva affermazione del criterio dei “fabbisogni standard”. Questo canone muove in sostanza dall’assunto che le risorse da destinare agli enti territoriali non vadano parametrati sulle loro spese, ma sul costo oggettivo dei servizi resi al cittadino; così, per parlare della sanità – una delle fondamentali voci di uscita del bilancio pubblico, finanziata attraverso l’IVA – si giudica inammissibile che per un’identica prestazione, consistente ad esempio in un’analisi del sangue, si riconosca una certa somma alla Lombardia, e magari il doppio alla Campania. Un apposito decreto attuativo, pertanto, affida ad una società di studi di settore il compito di determinare la spesa efficiente – valida sull’intero territorio nazionale, e per questo definita “standard” – per ogni funzione fondamentale di comuni e province.
Per un federalismo efficiente: meccanismi premiali e sanzioni
Il lettore interessato all’argomento reperirà facilmente, sulla stampa specialistica, informazioni dettagliate circa gli strumenti tributari – si tratta per lo più di addizionali e quote di compartecipazione regionale su imposte già esistenti – attraverso i quali gli enti locali potranno direttamente trattenere aliquote del gettito proveniente dal loro territorio. Qui preme solo mostrare come la logica complessiva dei decreti attuativi del federalismo fiscale tenda a delineare un sistema di ripartizione delle risorse pubbliche in grado di stimolare la competizione tra enti territoriali omologhi – e quindi una corsa all’impiego virtuoso ed efficiente dei mezzi disponibili – attraverso meccanismi di controllo sull’esercizio delle nuove autonomie. Si pensi al caso dell'IRPEF, la cui percentuale manovrabile da parte dei presidenti delle regioni, oltre ad essere sottoposta a specifici “tetti”, vivrà in rapporto di costante simbiosi con l’IRAP: dal 2014 potranno infatti ridurre e azzerare quest’ultima imposta solo le regioni che non avranno ecceduto con gli aumenti dell’IRPEF. L’autonomia, pertanto, in qualche modo si autoalimenta: ne conserverà e ne otterrà di più chi la saprà gestire meglio.
Lo stesso decreto presenta anche numerosi meccanismi premiali: il primo e più macroscopico prevede che l’ente che riesca a spendere meno delle risorse ad esso destinate in base al criterio dei costi standard, potrà trattenere il surplus; fermo restando, naturalmente, che il livello essenziale delle prestazioni pubbliche – cioè il minimum, quantitativo e qualitativo, di un dato servizio, al di sotto del quale gli enti locali non potranno scendere – sarà determinato una volta per tutte con legge dello Stato.
I decreti attuativi, inoltre, apprestano misure punitive nei confronti degli amministratori incapaci: il “governatore” che mandi “in rosso” la propria regione rischierà la rimozione dall’incarico, andando pure incontro ad un taglio dei rimborsi delle spese elettorali destinati alla lista che l’aveva sostenuto.
Per le ipotesi di definitivo dissesto dell’ente amministrato, la riforma non esita a delineare un vero e proprio “fallimento politico” a carico di sindaci e presidenti di provincia giudicati responsabili dalla Corte dei Conti: le sanzioni saranno l’ineleggibilità decennale e l’interdizione dalle cariche detenute presso gli enti pubblici.
Le contromisure ai rischi di sperequazione
Certo, il pericolo di disuguaglianze è dietro l’angolo, e sarebbe ingenuo nascondersi che qualora il federalismo fiscale venisse improvvidamente applicato senza gradualità né contemperamenti, finirebbe probabilmente per alimentare il divario tra nord e sud, minacciando persino l’unità nazionale, giacché le disparità assurgerebbero al rango di logica di sistema. Proprio per questo, la riforma oggi in fase di attuazione prevede anche dei meccanismi di compensazione degli squilibri: onde evitare che il reinvestimento sul territorio di provenienza dei capitali prodotti dalle regioni più ricche – e la conseguente sottrazione di parte degli stessi fondi a quel che è stata sin qui la loro destinazione, e cioè il ripianamento del debito delle regioni meno virtuose – inneschi un meccanismo perverso per cui i territori opulenti continuino a crescere e quelli poveri s’impoveriscano sempre più, saranno costituiti appositi fondi perequativi in favore di regioni, province e comuni più deboli.
Queste, per così dire, le buone intenzioni della riforma; permane ovviamente il rischio che la sua concreta attuazione frustri le aspettative, privilegiando le mire speculative di una parte del Paese a scapito dell’uguaglianza dei diritti e delle opportunità tra tutti i cittadini. Si tratta di una minaccia concreta che alimenta paure diffuse, le quali rischiano, a loro volta, d’imbrigliare ogni afflato riformatore, condannandoci all’immobilismo; sarebbe meglio esorcizzare queste paure con l’interesse e la partecipazione: nella fattispecie seguendo attentamente le diverse tappe dell’attuazione della riforma, e poi attivandosi affinché la propria voce giunga agli organismi politici decentrati, i quali saranno dotati di poteri e autosufficienza sempre crescenti. Il federalismo fiscale, potenziando le autonomie, promette, tra le altre cose, di dare maggior peso ai singoli: la defezione o il disinteresse da parte nostra sarebbero perciò la colpa più grave.
Marco Giorgetti